di Gianni Pantaleo.

Federico Maria Giansanti, regista.
Si scoprono realtà artistiche che lasciano segni nell’animo. Il teatro ha l’immediatezza dei suoi contenuti perché la visione di un’opera non ha necessità di essere interpretata dallo spettatore: fondersi con gli attori, libera l’emozione lasciandosi coinvolgere fisicamente, permettendo la comprensione di un dramma. Soprattutto quando questo riflette il dubbio di vivere solo per sé stessi o anche per gli altri. Questa che segue, è l’intervista ad un giovane regista e sceneggiatore, Federico Maria Giansanti, che con “Safe”, racconta la storia di una suora combattuta tra le sue paure e i suoi doveri di religiosa.
C’è una forte preparazione umanistica che si percepisce vedendo “Safe”, opera teatrale diretta da lei. La messa in scena non sarà stata una “passeggiata”. Non è tanto il numero degli attori in scena, quanto la profondità di Suor Daisy. Lei è giovanissimo ma pare abbia alle “spalle” anni di esperienza teatrale. Senza “scavare” il suo passato artistico, credo sia importante cominciare con il suo interesse per le emozioni che traduce in testi. Ci racconta?
L’esperienza teatrale che ho maturato è frutto di due fattori fondamentali, vale a dire lo studio e l’osservazione. Nonostante io sia principalmente un drammaturgo e un regista, ho avuto modo di studiare tutte quelle le materie che concernono la recitazione (voce, dizione, movimento scenico e palco, oltre drammaturgia e regia) presso il Centro Studi Acting di Roma dove mi è stato possibile apprendere e lavorare senza alcun giudizio. Questa libertà mi ha concesso di affidarmi e lasciarmi guidare con passione da Lucilla Lupaioli in un percorso accademico che mi ha permesso di assorbire tutto ciò che potevo per iniziare un mestiere dove non si finisce mai di imparare. Questa formazione, molto specifica, mi ha sempre facilitato nella trasposizione dell’idea in parole, e quindi nella scrittura, poiché mi ha dato modo di allenarmi in quello che tutti, attori e registi e autori, devono necessariamente fare quando affrontano un testo: porsi delle domande e chiedersi che cosa c’è di nostro in quello che si vuole raccontare, qual è la nostra urgenza e cosa si vuole comunicare esattamente allo spettatore. Per me nel caso specifico di “Safe” era importante raccontare quanto si possa andare a fondo e quanto si possa cercare di rimanere aggrappati all’ultimo bagliore di speranza, era urgente per me chiedermi se sperare in qualcosa e credere in qualcuno fossero la stessa cosa in termini di misticità in un momento come quello che abbiamo passato la scorsa primavera.
Il suo “debutto” da sceneggiatore. Quando le fu proposto di sceneggiare un racconto? Lo sceneggiatore non è uno scrittore e non è facile. Quali i confini tra uno scrittore e uno sceneggiatore?
Il mio primo testo l’ho scritto perché avevo degli amici attori che mi spronavano a scrivere per portare in scena degli spettacoli con cui provare a partecipare a dei bandi. Il mio primo lavoro è stato una commedia pulp a sei attori intitolato “La rapina”. Il mio obiettivo al tempo era portare qualcosa di vicino a Tarantino a teatro con un linguaggio contemporaneo, giovanile, con dei riferimenti alla beat generation per certi versi. La differenza tra uno scrittore e uno sceneggiatore sta nella rappresentazione e nell’utilizzo degli attori. Uno scrittore si avvale di personaggi che però crea il lettore immergendosi nella lettura, mentre uno sceneggiatore scrive la storia di alcune persone e quando scrive pensa esattamente a una tipologia di individuo che potrà interpretarlo per rendere vivo il personaggio. Quando io scrivo penso sempre a come sarà visto e a chi lo porterà in scena, questo è un passaggio che nella narrativa non c’è.

Sceneggiatore e regista sono mai in “conflitto” tra loro? Lei è entrambi. Ha momenti in cui non soddisfa l’esecuzione del lavoro fatto dall’uno e poi dall’altro?
Ogni spettacolo lo scrivo per come lo vorrei vedere e probabilmente alla fine lo vedo per come avrei voluto scriverlo. Per quanto mi riguarda, anche se si tratta di me stesso, è come se uno continuasse il lavoro iniziato dall’altro. Ho scritto per dei registi, trovo divertente dialogare e cercare di tradurre in parole i pensieri che escono fuori dopo ore di dialogo e ricerca. La scrittura spesso è un’attività collettiva, anche quando scrivo i miei spettacoli o sceneggiature ci sono pezzi di conversazioni realmente accadute o aneddoti di vita vissuta, non credo molto nella scrittura solitaria e senza contaminazioni.
Riconosco una capacità intellettuale e psicologica molto profonda. Nel lavoro del teatro, spesso l’artista è in “analisi”. Un percorso indispensabile per l’introspezione dei soggetti in scena. Le è mai capitato di “essere” più soggetti nella stesura di una sceneggiatura? Degli esempi?
Cerco sempre di pensare come le persone di cui scrivo, in fondo noi autori scriviamo di persone e non di personaggi, il personaggio è il risultato dell’interpretazione dello scritto da parte dell’attore. Scrivendo di persone m’immedesimo sempre e cerco sempre di chiedermi che cosa farei o dire o penserei io in una determinata situazione. Spesso chiedo pareri, faccio leggere i miei stralci e i miei appunti a persone che non scrivono e che non sono del settore per avere un parere che derivi dall’istinto e non dalla preparazione.
Più di tre quarti d’ora di monologo. Valeria Wandja è strepitosa. Studi, laboratori, workshop…una preparazione dignitosissima per arrivare a “essere” Suor Daisy. Ha già lavorato con lei? Con quali “criteri” ha, mi scuso per il termine, “scelto” Valeria Wandja?
Secondo me Valeria ha un enorme talento, io ho studiato in alcuni corsi intensivi di recitazione con lei e ho sempre avuto voglia di lavorarci insieme perché è una professionista esemplare in termini di preparazione al lavoro e puntualità e rispetto del lavoro e cura dei dettagli. Valeria ha lavorato con me nel mese di agosto, preparando uno spettacolo basandolo solo sull’esperienza sensoriale per quanto riguarda la ricreazione dell’ambiente. L’ho scelta perché cercavo una ragazza giovane, che sapesse recitare in inglese, che avesse voglia di sfidarsi e che fosse preparata. Sapendo che viene dalla mia stessa accademia ho creduto di potermi davvero fidarmi di lei perché sapevo che saremmo stati affini nel modo di concepire il lavoro e così è stato, la fiducia è stata pienamente ripagata.

Valeria Wandya, attrice.
Guardando la piece teatrale, si assiste ad un profondo senso di inquietudine che la protagonista percepisce prima intimorita, ma poi fiduciosa, aggrappata alla fede, mestamente, ritorna alla sua vita dedita agli ammalati. Si prova anche un gran senso di serenità interiore. Sono sentimenti, questi, che ha vissuto lei come uomo?
Non saprei… quando ho scritto “Safe” ero partito dalla mia situazione di inquietudine dovuta alla solitudine che provavo in quel momento. Mi chiedevo cosa stessi aspettando, in cosa stessi sperando e che cosa avrei dovuto capire da questo momento. Sicuramente mi sono aggrappato all’idea di poter tornare a teatro un giorno e perciò per me quella è stata la mia fede.
Crede che l’attuale inquietudine sia causa della pandemia in corso?
Assolutamente sì, a oggi ancora non ci sono soluzioni definitive. Ci sono settori in crisi nera e senza precedenti, persone che non sanno di che vivere tra due mesi. La pandemia ha portato a galla i problemi del lavoro in nero, della poca istruzione e curiosità in cui versa il paese e la fragilità del mondo del lavoro.
Può la fede aiutarci?
La fede aiuta chi crede perché è un patto che non può essere messo in discussione. Per questo ci si affida al proprio Dio, perché è l’unico di cui non si può mettere in discussione il modo di operare. Bisogna capire in chi o cosa abbiamo fede. Per me sì perché so che il teatro non può morire finché esisterà qualcuno che impererà un monologo a memoria.
La “potenza” del Signore, scuote la forza di Suor Daisy che con dovere, accetta il suo ruolo di carità verso gli uomini. Non pensa che questo possa essere un messaggio a tutti noi che data la pandemia, pare non si sia diventati più “buoni”? La dolcezza di Suor Daisy, dovrebbe essere un monito. Percepisco male?
Suor Daisy ci racconta che purtroppo ci sono delle cose che dobbiamo accettare per quelle che sono e andare avanti senza lasciarsi travolgere dagli eventi. Suor Daisy reagisce, si arrabbia, si dispera ma poi comprende che non può nulla di fronte a qualcosa d’imprevedibile e più grande di lei. Però ci insegna anche cosa significa essere uniti, che cos’è la cooperazione per uno scopo comune, ci dice che si è più forti se si è insieme e che si è migliori se si è volti nella stessa direzione. Ci parla di comunità come insieme di persone che hanno come nome la parola “noi”.
C’è un karma nel dialogo di Suor Daisy con il Signore di un dramma interiore che intenerisce. Il “dolore” che prova Suor Daisy sembra un dolore provato per gli altri più che per la sua vita confinata. La sceneggiatura è un’ode alla solitudine intesa come scelta e all’introspezione. Sono riflessi della sua preparazione spirituale? Non mi fraintenda, nulla di legato alla religiosità, ma ad un senso di appartenenza all’universo.
Noi dobbiamo aver cura degli altri. Spesso si dice che dobbiamo lasciare questo pianeta meglio di come l’abbiamo trovato e io credo che questo sia vero e doveroso. Credo inoltre che ogni uomo abbia il dovere di rispettare il prossimo e aiutarlo perché dall’aiuto comune nasce l’intesa per una soddisfazione globale. Belle parole difficili da tradurre infatti, lo capisco, però credo che si debba iniziare veramente a parlare più spesso di come saremo in termini di comunità e non d’individui. La società di adesso è prettamente individualista e questo è un tipo di atteggiamento da correggere per come la penso io.

Progetto FMG: una formazione di spessore artistico e culturale notevole. Non nascondo la curiosità futura per altri lavori. “Safe” e mi scuso per l’impreparazione, mi ha permesso di conoscere questa realtà teatrale. Le lascio tutte le parole che desidera: mi spiega il progetto? Ovvero: ci faccia “innamorare” della compagnia, cioè di Voi.
Adesso continuiamo a portare in giro (virtualmente) “Safe” che dal 22 al 28 marzo sarà in streaming in occasione del Fringe Festival di Newcastle (Australia). Siamo contenti di aver preso parte al Fringe Festival di Salt Lake City (Utah), di Asheville (North Carolina) e di continuare con altri festival quali il Fringe di Hastings (Inghilterra) e Ashland (Oregon). Porteremo sicuramente “Safe” in scena a Roma non appena si potrà tornare in scena dal vivo e in presenza. Per il momento stiamo spaziando cercando di offrire opportunità di lavoro e crescita che al contempo ci possano arricchire umanamente e artisticamente offendo al pubblico l’opportunità di trovare contenuti culturali sui nostri canali. L’ultima iniziativa ci vede impegnati sul fronte dei podcast dove, insieme a Davide Manfrevola, abbiamo ideato il progetto “Itaria He Ikitai”, ovvero delle puntate audio in giapponese dove proponiamo il racconto delle bellezze di Roma e del nostro paese a un pubblico di ascoltatori nipponici. Davide è ragazzo estremamente bravo nel parlare giapponese e nel raccontare la nostra storia, averlo incontrato e potuto inglobare il suo progetto nella nostra idea di diffusione culturale è stata una vera fortuna. Il progetto “Itaria He Ikitai” è disponibile su Spotify, Spreaker e i principali diffusori di podcast cercando per l’appunto FMG Produzione – Itaria He Ikitai.
“…aver cura degli altri”, lo dice Federico Maria Giansanti. Avere cura degli altri non è solo un dovere morale perché siamo uomini, ma soprattutto è un dovere spirituale che va ben oltre l’essere uomini: è un atto d’amore per l’Altissimo, senza dimenticare che è stato Uomo e che è molto, molto più Infinito di noi umani. Che si creda o no…
Gianni Pantaleo.
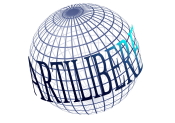 Arti Libere Web magazine di arte e spettacolo
Arti Libere Web magazine di arte e spettacolo






