di Yuleisy Cruz Lezcano.
L’autodeterminazione femminile e la lotta contro la donna stereotipata sono due aspetti fondamentali, che hanno attraversato le lotte e le riflessioni femministe lungo i secoli, unendo le istanze di libertà, autonomia e uguaglianza per le donne.
Il principio di autodeterminazione, per esempio, si basa sulla capacità delle donne di decidere liberamente sul proprio corpo, sulla propria vita e sul proprio destino, al di là delle imposizioni sociali, culturali e politiche.

Olympe de Gouges (1748-1793)
Invece, la lotta contro la visione stereotipata della donna si basa su una ristrutturazione dei modelli comportamentali e sui valori sociali distorti, in modo di stravolgere gli archetipi tradizionali che riducono la figura della donna a madre, angelo, moglie devota o oggetto sessuale.
Sin dalle prime voci femministe, pensatrici e scrittrici hanno lottato per il riconoscimento dei diritti delle donne e per la possibilità di autodeterminarsi.
Diverse figure storiche e contemporanee, da Olympe de Gouges a Mary Wollstonecraft a Sor Juana Inés de la Cruz, hanno contribuito alla definizione di questo concetto.

Mary Wollstonecraft (1759-1797)
Infatti, una delle domande più difficili e provocatorie sollevate dalla letteratura e dalla psicologia della violenza di genere riguarda la possibilità di recupero e reintegro sociale degli aggressori.
In molte delle opere letterarie e poetiche, la figura dell’aggressore non è mai semplicemente demonizzata, ma viene messa in discussione nel contesto di una cultura che alimenta e giustifica le disuguaglianze di potere tra i sessi. La violenza, infatti, non è solo un atto individuale, ma spesso il prodotto di un sistema che normalizza certi comportamenti e che può produrre vittime anche tra gli stessi carnefici.

Juana Inés de la Cruz (1648-1695)
La letteratura maschile, pur avendo dato voce ad alcune figure femminili di grande valore, ha storicamente perpetuato visioni parziali e limitanti della condizione femminile.
Anche quando gli scrittori si sono espressi in termini di empatia verso la figura femminile, la loro prospettiva è rimasta spesso influenzata da un punto di vista patriarcale.
Le voci di donne che si fanno sentire in testi scritti da uomini appaiono quasi sempre stilizzate.

Victor Hugo (1802-1885)
Nel XIX e XX secolo, alcuni scrittori maschi come Victor Hugo in «Les Misérables» o Charles Dickens in «Bleak House» hanno creato personaggi femminili forti, ma spesso l’intento era quello di rappresentare l’ideale di una donna che si sacrificava per gli altri o che era vittima delle circostanze.
Non si trattava di personaggi che si autodeterminavano pienamente, ma di donne che agivano all’interno dei confini sociali imposti.
Queste narrazioni, pur essendo pionieristiche in alcuni aspetti, non riuscirono a rompere completamente con gli archetipi tradizionali.

Charles Dickens (1812-1870)
Il femminismo visto dalle donne si distingue radicalmente da quello proposto dalla letteratura maschile. Le scrittrici femministe hanno iniziato a lottare per una rappresentazione più autentica e complessa della condizione femminile, a partire dal femminismo delle suffragette e dalle teoriche del XIX secolo come la scrittrice e studiosa Mary Wollstonecraft (1759-1797), che ha anticipato i temi del femminismo pubblicando nel 1792 il manifesto «Rivendicazione dei diritti della donna».

Il mondo femminile della letteratura e dell’arte è pieno di storie di autodeterminazione e trasformazione, potrei per esempio ricordare Ida Laura Pfeiffer (1797- 1858), che è stata un’intrepida viaggiatrice, ricercatrice e scrittrice.
La donna visitò, con un budget ridotto all’osso, zone pericolose, e pubblicò numerosi resoconti di viaggi e divenne la prima donna ad essere ammessa come membro onorario alle Società Geografiche di Berlino e Parigi, sfidando il proprio tempo.

Ida Pfeiffer
La storia di questa donna mette in evidenza l’importanza di prendere il controllo delle proprie vite e delle decisioni, dimostrando che l’indipendenza e l’autodeterminazione sono essenziali per raggiungere un potenziale personale.
Parlando di questo argomento si sta rilevando sempre più fondamentale la spinta culturale anche nel mondo del cinema, per esempio un film bellissimo e che ha avuto una meritata accoglienza nel mondo del grande schermo è stato il film «Thelma & Louise», in cui non è presente per niente il fattore vittimismo né disprezzo per l’uomo, ma un canto di audacia e di libertà.

Era l’anno 1991 quando questo film usciva in anteprima nei cinema di tutto il mondo: nessuno, nemmeno il suo direttore Ridley Scott né le protagoniste Geena Davis e Susan Sarandon, avrebbero previsto l’esito inatteso avuto dal film, ma soprattutto l’impatto culturale con il quale seppe dare un’inflessione alla figura femminile.

Per comprendere tale esito bisogna analizzare il panorama psicologico, i traumi dei personaggi e anche le loro vita, così come il contesto sociale.

Geena Davis
Thelma & Louise di fatto rappresentò un grido alla libertà e all’emancipazione femminile, in un’epoca in cui la figura della donna stava attraversando un profondo cambiamento culturale.

Susan Sarandon
In questo film si può cogliere il desiderio di indipendenza, di autodeterminazione delle donne.
Yuleisy Cruz Lezcano.
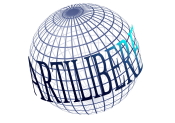 Arti Libere Web magazine di arte e spettacolo
Arti Libere Web magazine di arte e spettacolo






